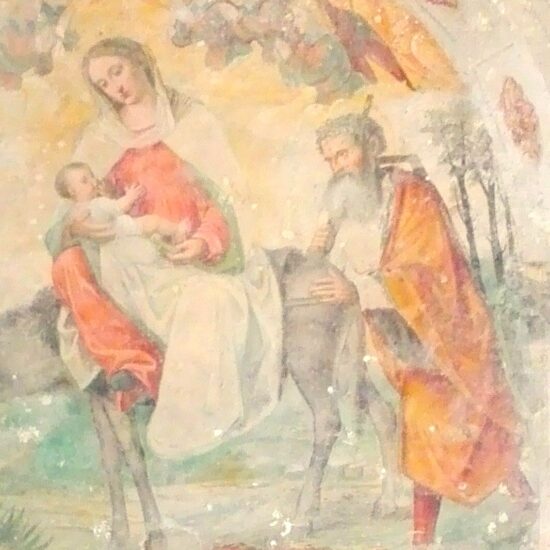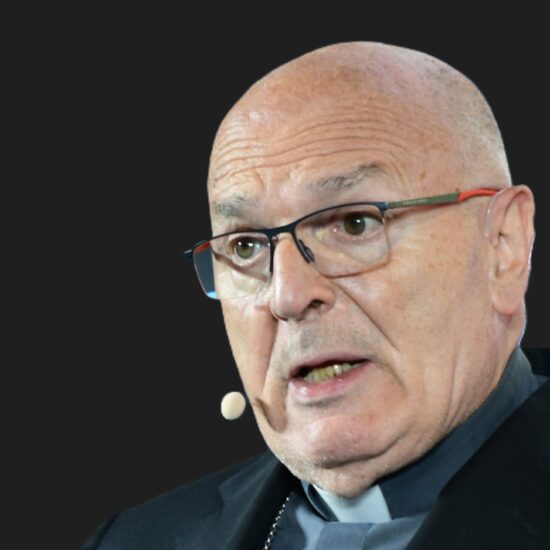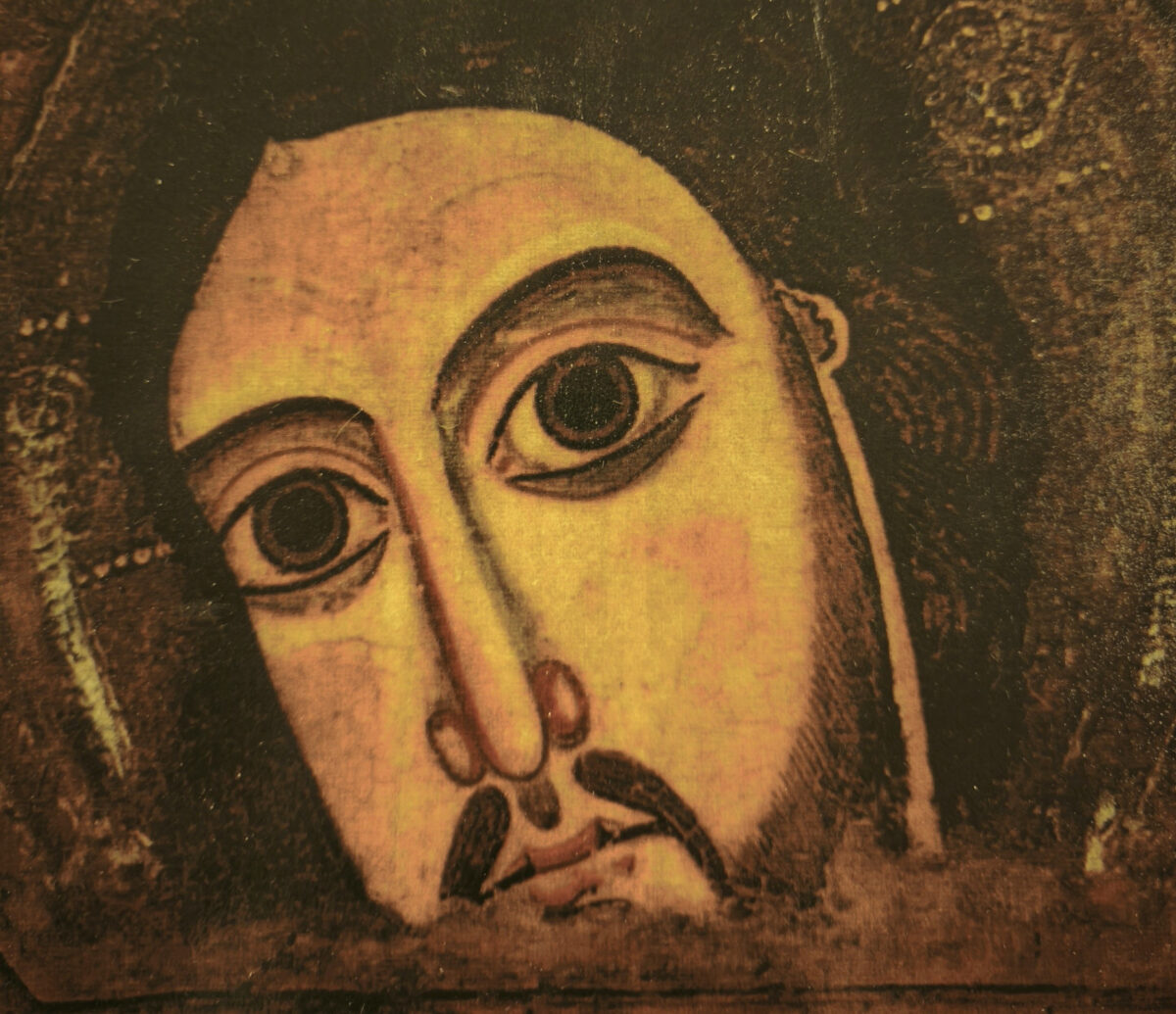
Pubblichiamo il podcast e la trascrizione di una meditazione sul capitolo quarto del Vangelo di san Luca, tenuta da mons. Luigi Negri, di fronte a un gruppo di amici, il 30 marzo 2018 a Milano.
«Si recò a Nazaret, dove era stato allevato» (Lc 4,16). Si recò a Nazaret, si reca da noi, dove è stato allevato. Anche noi, in questi anni, pochi o tanti, abbiamo allevato il Signore, lo abbiamo custodito nella nostra vita. Ci siamo sorpresi tante volte a guardarlo come l’ospite silenzioso e tenero. L’abbiamo custodito. Perciò va bene anche per noi che si recò a Nazaret dove era stato allevato. Si reca da me, vien da me ed entra nello spazio della mia vita che in qualche modo, con tutti i limiti, con tutte le infedeltà ha cercato di allevarlo, di custodirlo. La dignità della vita non è che uno si vede riconosciuti i suoi diritti civili dalle istituzioni democratiche o meno a cui appartiene. La dignità della mia vita, mi dispiace per tantissime autorità “sopraelevate”, la dignità della vita consiste nell’essere figli di Dio e la figliolanza da Dio non si merita e non si compra. La figliolanza di Dio è un dono gratuito che ci sorprende la prima, come l’ennesima volta, aprendo nella nostra vita il sentiero buono dell’esistenza, come diceva Benedetto, il sentiero buono dell’esistenza, il sentiero che rende la vita un cammino verso la positività e non il sentiero negativo e triste alla fine del quale la vita appare in tutta la sua radicale inconsistenza.
«Ed entrò, secondo il suo solito, di sabato nella sinagoga e si alzò a leggere» (Lc 4, 16). Per noi il Signore, dalla sua morte e risurrezione, non entra più nella sinagoga. Sta nella sua Chiesa. Perché il luogo dove il Signore è permanentemente presente, fino all’ultimo giorno, è la sua Chiesa. «Ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo» (Mt 28, 20). Entra qui, ma in qualche modo è come se fosse la prima volta. E noi, quando leggiamo i Vangeli, ci sorprendiamo identificandoci nell’uno o nell’altro incontro, perché gli incontri del Signore con i suoi insegnano anche a noi. Gli incontri del Signore con i suoi riproducono nella loro unità e nella loro diversità momenti vari della nostra vita, del nostro incontro con Lui. Per questo Giussani ha sempre utilizzato molto i Vangeli e noi siamo presi per mano e rileggendo i momenti dell’incontro siamo aiutati a scoprire sempre di nuovo gli aspetti nuovi e attuali del nostro incontro con Lui.
Dunque, ci si ripresenta oggi dove è stato allevato ed entra non nella sinagoga che è una profezia limitata, parziale, fallibile, superabile della presenza di Dio in Cristo. È la Presenza reale. Cristo presente nella sua Chiesa, qui ed ora. «Gli fu dato il rotolo del profeta Isaia. Apertolo, trovò il passo dove era scritto: “Lo Spirito del Signore è sopra di me; per questo mi ha consacrato con l’unzione e mi ha mandato per annunziare ai poveri un lieto messaggio, per proclamare ai prigionieri la liberazione e ai ciechi la vista; per rimettere in libertà gli oppressi e predicare un anno di grazia al Signore”. Poi arrotolò il volume, lo consegnò all’inserviente e sedette. Gli occhi di tutti nella sinagoga stavano fissi sopra di lui» (Lc 4, 16-20). L’incontro che si ripresenta diventa un ulteriore pezzo di storia nella vita dei primi come nella nostra, se i nostri occhi sono fissi su di Lui. «Gli occhi di tutta la sinagoga erano fissi su di lui». Quando si legge questo brano sembra di vedere una proiezione, un pezzo di un film. È così mordente il racconto, ci coinvolge perché a Nazaret c’eravamo tutti, ma non per un uno svolazzo sentimentale, mi spiego, non per uno spiritualismo d’accatto gesuitico. C’eravamo oggettivamente tutti, per il mistero della nostra chiamata, che si è consumata in un certo momento della nostra vita, meglio è iniziata con il momento del nostro battesimo e si è maturata poi per gli incontri in cui il battesimo ha preso e ripreso consistenza e forza, c’eravamo anche noi. Siamo dentro questa grande compagnia fin dall’inizio e siamo dentro questa grande compagnia oggi. E come diceva il beato cardinale Newman, siamo dentro meglio di loro, dei primi, perché i primi hanno capito Cristo meno di noi. Perché noi utilizziamo tutto il grande cammino secolare che la Chiesa ha fatto e al quale ciascuno dei suoi figli ha cercato di contribuire per quello che poteva. Noi abbiamo una coscienza di Cristo, del suo valore, dei nostri limiti, delle prospettive della nostra vita con Lui, non dico definitivo, ma che ha una certa adeguata consistenza.
Dunque, viene oggi e dice di sé, si presenta. Le parole del Signore nei Vangeli sono sempre un’auto-presentazione, un’auto-comunicazione. Tutta la vita di Cristo era un’auto-comunicazione di Dio, ma in questa auto-comunicazione di Dio, che è la sua vita, le parole, le sue parole, hanno un valore straordinario perché illuminano l’esperienza. La sua presenza senza le parole risulterebbe ultimamente incomprensibile e inincidente. La sua presenza, arricchita dalle sue parole, ci parla.
Quindi il Signore si ripresenta oggi nel nostro appartenere alla Chiesa, si ripresenta con tutta la profondità della sua proposta. «Lo Spirito del Signore è sopra di me; per questo mi ha consacrato con l’unzione e mi ha mandato per annunziare ai poveri un lieto messaggio, per proclamare ai prigionieri la liberazione e ai ciechi la vista; per rimettere in libertà gli oppressi e predicare un anno di grazia al Signore». Il Signore si ripresenta come il redentore, il Redentore che redime la nostra vita che altrimenti avrebbe camminato, più o meno velocemente, percorrendo il sentiero polveroso del nulla. «Allora cominciò a dire: “Oggi si è adempiuta questa Scrittura che voi avete udita con i vostri orecchi”» (Lc 4, 21).
Io cerco di immedesimarmi, quando leggo questo brano, con il sentimento di quel manipolo di persone che lo stavano ascoltando, credo non fossero più di qualche decina. «Oggi si è adempiuta questa scrittura che voi avete udito con i vostri orecchi». Apparentemente non era cambiato niente. Non era cambiato niente. L’avvenimento non aveva il carattere di un’innegabile straordinarietà, non era cambiato nulla, ma soprattutto loro erano della povera gente. La povertà è una condizione di vita che accompagna l’uomo. La povertà morale non è meno grave della povertà fisica, della povertà materiale. La povertà affettiva, la solitudine. La povertà è la cifra dell’umanità, guai se la si stringe in modo univoco. Quindi il Signore è venuto per i poveri. Sant’Agostino, sta candendo in dimenticanza anche lui, ma è il più grande fra i grandi, diceva: “I poveri sono gli uomini”. Non sono gli uomini poveri, sono gli uomini. E aggiungeva lui, con un filo di cattiveria comprensibilissima, che i più cattivi, i più poveri, sono quelli che pensano di essere ricchi e che, quindi, affidano la loro vita, nonostante tutto quello che possiedono, o alla fama che hanno ricevuto o al nome che si son fatti. I più poveri dei poveri sono quelli che credono di essere ricchi, perché questi più poveri fra i poveri, i ricchi, i ricchi delle proprie sostanze intellettuali o morali, sono quelli che hanno fronteggiato il Signore e l’hanno rifiutato. Sono quelli che l’hanno lasciato parlare come un fesso per poi, come dire, prenderlo in giro, come raccontano i Vangeli degli ultimi giorni. I poveri sono gli uomini. Se è venuto per i poveri, vuol dire che è venuto per gli uomini, non per una certa categoria di uomini.
Allora, questa proposta incredibile, si è ripresentato a Nazaret e ha detto questo. Era un anno, forse più, che girava per le loro strade, che parlava a loro, ma ha riproposto la sua immagine. A questi, come a noi, ci dice questa mattina: “questa promessa si è adempiuta davanti a voi”. Quella gente lì si sarà chiesta: “ma cosa cos’è che si è adempiuto?”; “Tutti i problemi che avevo ce li ho ancora. Che cos’è che si è adempiuto?”. Questa proposta è la sua Presenza. Punto. Questa auto-presentazione di Dio coincide con la presenza di Cristo. Il contenuto del primo incontro come del centesimo è questo. “Oggi si è compiuta questa profezia, accade davanti ai vostri occhi e sono Io”, ci dice il Signore, “ma sono Io in voi. Sono Io con voi. Sono Io per voi, cioè sono Io nel mistero della Chiesa”. Perché è solo nel mistero della Chiesa che Cristo si rende presente come il Dio con noi, per noi.
«Tutti gli rendevano testimonianza ed erano meravigliati delle parole di grazia che uscivano dalla sua bocca e dicevano: “Non è il figlio di Giuseppe?”» (Lc 4, 22). Hanno trovato il contesto parentale in cui era nato, perché il contesto parentale ci rende tutti un po’ simili. Non è vero che ci renda uguali, ma ci rende tutti un po’ simili. Quindi dir dov’era nato, chi era stato il padre, voleva dire, insomma, “non metterla giù più dura di tanto”, “sei come noi”. «Ma egli rispose: “Di certo voi mi citerete il proverbio: Medico, cura te stesso. Quanto abbiamo udito che accadde a Cafarnao, fallo anche qui, nella tua patria!”. Poi aggiunse: “Nessun profeta è bene accetto in patria. Vi dico anche: c’erano molte vedove in Israele al tempo di Elia, quando il cielo fu chiuso per tre anni e sei mesi e ci fu una grande carestia in tutto il paese; ma a nessuna di esse fu mandato Elia, se non a una vedova in Sarepta di Sidone. C’erano molti lebbrosi in Israele al tempo del profeta Eliseo, ma nessuno di loro fu risanato se non Naaman, il Siro”». Questa citazione significa per il Signore presentarsi come l’emergenza definitiva e insuperabile del mistero di Dio. E questo fa scattare un odio fra quelli che lo ascoltano e Lui con il consueto tentativo di eliminarlo al quale Egli ha saputo sempre sottrarsi con molta intelligenza.
Perché ho letto questo? Perché questo è il nostro momento. Questo è il nostro momento. Questo è il momento del nostro oggi. Il nostro oggi in cui il Signore si ripresenta un’altra volta come portatore del senso profondo e ultimo della nostra vita. Non c’è nient’altro che questo. Perciò se al momento del suo incontro son qui arroccato in me stesso a vedere quel che va o che non va, Lui se ne va da un’altra parte. Lui se ne va da un’altra parte, o meglio, io non son presente e, quindi, Lui se ne va da un’altra parte. Viene a bussare: «Ecco, io sto alla porta e busso» (Ap 3,23). Io credo che di tutta la parola scritta, la parte finale dell’Apocalisse sia la cosa più grande. Lui viene a bussare alla nostra finestra, alla nostra porta, bussa, bussa… Se scendi e apri, entra. Anzi, il testo fa emergere chiaramente la presenza della Trinità: «noi (il Figlio e il Padre) verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui» (Gv 14, 23). I Padri della chiesa dicevano che così l’anima dell’uomo diventa il luogo della presenza di Dio, perché Dio viene a dialogare con noi entrando nella concretezza della nostra esistenza anche fisica: «non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me» (Gal 2, 20). Ecco, ci si ripresenta così, carico di questa grande pretesa che è già accaduta e sta accadendo. È questa la questione.
Dopo dieci anni, vent’anni, trent’anni, cinquant’anni per me, si ripresenta oggi e dice: “questo avvenimento è il tutto della tua vita”, “Se hai in mente qualcosa d’altro, sei un pirla”. Non perché le altre cose non abbiano valore. Ma non facciamole diventare l’idolo. La grande negazione di Dio nell’Antico Testamento è proprio il mettere accanto a Dio quegli idoletti che andavano a prendere prestito fra i popoli che li circondavano, negando così la loro grande originalità religiosa e culturale. La loro non è una delle religioni possibili, presenti e la forma di questa non è una delle varie forme. Tanto falso ecumenismo di oggi è tagliato alla radice oltre duemila anni fa. È Dio presente in Cristo. È Lui che domina l’esistenza. Mettiamo lì i nostri i nostri idoletti, la famiglia, il benessere fisico, la corrispondenza psicoaffettiva e tutte le altre cose che facciamo diventare valori, perché noi siamo disposti a considerare attentamente le promesse che devono realizzarsi. Siamo abilitati a fare anche una serie di osservazioni culturali o para-culturali su queste promesse che lungo la storia millenaria dell’umanità sono state proposte. Noi riusciamo a far discorso di tutto. Riusciamo a far discorso di Dio senza aprirci alla sua presenza.
Il problema è un altro, che questa cosa non deve accadere, è già accaduta. Questa cosa è dentro la tua vita, è entrata di botto. Puoi essertene dimenticato per degli anni. È entrata di botto quando ti han battezzato. Poi per degli anni è come se fosse rimasta nel fondo più profondo della tua coscienza, poi improvvisamente, attraverso una trama di incontri, si è riproposta. Noi abbiamo sempre usato giustamente la parola conversione perché la seconda, terza, quarta conversione son più profonde della prima. Nella prima tutto avviene con un certo impeto, con una certa imprecisione, con una certa approssimazione… ma la seconda, la terza, dopo dieci anni… ridire dopo dieci anni “io sto con te”, ridire dopo dieci anni “io credo che tu sei il Figlio di Dio” … e infatti le professioni di fede che sono state nei primi, come per noi, i punti che portano la vita, hanno tutte un loro tempo, non sono tutte uguali. La Chiesa ripropone le professioni di fede di Pietro, ma le professioni di fede di Pietro sono un crescendo: dal riconoscimento che Egli, il Signore, è il senso profondo della vita, «Tu solo hai parole che danno la vita eterna» (Gv 6, 68), a quello finale. E quello finale non è “ho capito tutto di te, ho capito che sei il Figlio di Dio, la seconda persona della Santissima Trinità, eccetera”. L’elemento estremo della fede in Cristo, è che io sono capace di volergli bene. «Pietro, mi ami tu più di loro?», «Certo, Signore, tu lo sai che ti amo» (Gv 21, 15). La domanda di Cristo non è se hai capito, la domanda di Cristo a me è se gli voglio bene.
E questo è il problema di oggi, sarà anche di domani, certamente, ma è di oggi. È di oggi, sempre per il cristiano, ma soprattutto quando la Chiesa fa memoria di Lui che ci salva, cioè muore e risorge: riconoscere che la sua profezia si è compiuta in me e posso dirlo con estrema sicurezza, perché il contenuto di questa certezza non è quel che io penso, ma è il cuore della Chiesa che me lo attesta. Perché le cose più importanti della vita, che sono quelle su Dio e sull’uomo, non le conquistiamo con la nostra intelligenza, le accogliamo da quella Santa Chiesa di Dio che è l’unica a dirle e, se non le dice, sarà maledetta anche lei alla fine. Se non dice queste cose per dirne altre, andando alla ricerca del benessere mondano, mettendosi d’accordo con la con la mentalità di questo mondo… «Non vogliate assecondare la mentalità di questo mondo». Paolo ha detto decine di volte questo.
Dalla parte dell’uomo, l’uomo fa l’esperienza del tradimento, lo fa sempre. Il Signore si ripresenta e l’uomo fa sempre l’esperienza del tradimento. Può diminuire, può aumentare, può segnare in maniera pesante l’esistenza, ma c’è un modo per non accorgersi. È quella, come dire, insensibilità alla nostra umanità che ci caratterizza. Non ci accorgiamo neanche di quel che siamo, soprattutto perché abbiamo isolato il nostro essere nelle cose che ci interessano di più. Se io sono i soldi, se io… tutto il resto… La profezia è in atto, la profezia è da riconoscere ogni volta, ma è qui il tradimento. È un tradimento di mentalità. Il peccato è un’altra logica nella vita. Il peccato sono altri ideali nella vita. Il peccato è avere una concezione di sé in cui, se formalmente ogni tanto diciamo Cristo, non sentitevi a posto, perché nella maggior parte dei casi, lo dico per me, quando parliamo di Cristo, ne parliamo formalmente e quanto più sembra essere preciso il discorso, tanto più è formale la sostanza. La profezia sta accadendo, accade e accade nella misura in cui io ragiono secondo la fede. Cioè, faccio della fede il fondamento del modo di vivere e di giudicare. Questa è stata la genialità umana e cristiana di san Giovanni Paolo II, questa, non altro. Quindi per noi la questione è un autentico senso della fede, che la fede sia il criterio ultimo di giudizio e di azione. Ragionare secondo Cristo, prima lettera ai Corinti, «noi abbiamo il sentimento di Cristo, noi abbiamo il pensiero di Cristo». Allora, uscire da questo peccato sulla mentalità e riacquisire la mentalità della fede, è qui che si rinnova la conversione. Perché la conversione degli inizi che si ripropone sempre è una conversione della mentalità.
Questo è la questione di questi giorni. Io non so come dirlo diversamente. È quello che riconosco e che attendo che riaccada nella bellezza dei riti, perché i riti della Settimana Santa sono un poema. C’è una ricchezza intellettuale, morale, artistica, incredibile. Il rito cattolico è la genialità di Dio che si incontra con la genialità dell’uomo. I riti della Settimana Santa sono il punto più alto della genialità di Dio che si incontra con la genialità dell’uomo.
Ecco, siccome questo richiamo viene dopo il Giovedì Santo, in cui abbiamo già fatto l’esperienza della messa nella cena del Signore, dicevo ieri (qui l’omelia), pensate quante volte il Signore avrà mangiato coi suoi. Era una vita normale, era una convivenza, mangiavano, avevano lasciato le case, perciò dovevano…, pensate chissà quante volte… Eppure la Chiesa dice: “No, no, no. Questa è la cena del Signore. È la cena in cui il Signore si presenta come amico del suo popolo. È la cena in cui il Signore fissa i termini di questa sua presenza amicale e i termini sono il sacramento del pane e del vino. I riti della Settimana Santa sono lo splendore, lo splendore della condiscendenza di Dio, che Dio condiscende alla mia umanità, e lo splendore della mia mia umanità che accetta di rispondere alla condiscendenza di Dio. «Signore, tu sai che ti voglio bene».
Io credo di potervi fare questo augurio adesso, mentre le vicende rotolano, mentre non ci viene risparmiato nessuna sofferenza: per noi avvenga veramente questo passaggio dalla fede come conoscenza alla fede come amore. Ma, se la se la fede come amore vien dopo una conoscenza, è un amore reale. In Pietro l’amore è venuto dopo che si era accorto che nessuno parlava come Lui: «Signore, da chi andremo?» (Gv 6, 68). Cioè, l’amore è stato l’espressione matura della sua intelligenza. Aveva cercato di capire quel che il Signore diceva. Aveva sperimentato duramente che non ce la faceva, non capiva. E poi, improvvisamente, uno spiraglio. Nessuno ha mai parlato come quest’uomo. E allora? E allora l’avventura dell’amore che prosegue l’intelligenza e compie l’intelligenza: a uno come Cristo non ci si può fermare dicendo “ha detto delle cose giuste”. Allora che nel nostro cammino maturi, si compia in qualche modo, l’esperienza dell’intelligenza e nasca l’esperienza dell’amore. E la domanda profonda della giornata, quella che dobbiamo rivolgerla a noi stessi, è il riverbero di quella che Lui rivolge: “Mi ami tu?”. Abituiamoci in questi, io lo dico per me, ultimi anni della vita, abituiamoci a sentirci sostenuti da questa domanda. La nostra giornata si apre col desiderio di risentire questa domanda e di sapervi rispondere. E questo si porta dietro positivamente tutte le cose buone e ci rende pazienti con le cose non buone. Capiamo che la vita ha finalmente il suo centro affettivo. Se voi leggeste, rileggeste i libretti di GS, vedreste che la parola “centro affettivo” è fra le prime che Giussani ha usato, ma dicendo che solo nella comunità concreta, storica il Signore diventava il centro affettivo della nostra vita. Perché fuori dalla Chiesa, di questo Cristo di cui si ciancia, non esiste più niente. Travolto dal tempo, come ogni avvenimento umano, è distrutto dal tempo come ogni avvenimento umano, così che tutto quello che sono riusciti a salvare gli intellettuali paracattolici è il suo insegnamento da analizzare, da contestualizzare, da aggiornare. E ci siamo sentiti dire autorevolissimamente che il problema della Chiesa oggi è che venga contestualizzato il discorso della fede. E chi lo fa? Gli intellettuali, i filosofi e i teologi. Come se la Chiesa fosse un popolo affidato ai saggi, così la mia mamma non avrebbe potuto neanche andare in Chiesa perché due terzi delle cose che dicono adesso e dicevano allora non le capiva. Questa profezia accade, ma questa profezia accade se noi ci assumiamo la nostra responsabilità, che non è quella genericamente di superare il male: il problema non è fare dei passi per uscire dal male, il problema è consegnare la vita all’unico che può cambiarmi la vita. La morale è lasciar dilagare il potere di Dio nella mia vita.
Quindi, che l’Avvenimento del Signore che ci si ripresenta, in questa piccola Nazaret che è la nostra vita di oggi, che il Signore che ci si ripresenta sia da noi riconosciuto, per la prima o per la centesima volta, ciascuno di voi sa come vive, come il centro affettivo della vita: «Signore, tu sai che ti voglio bene».