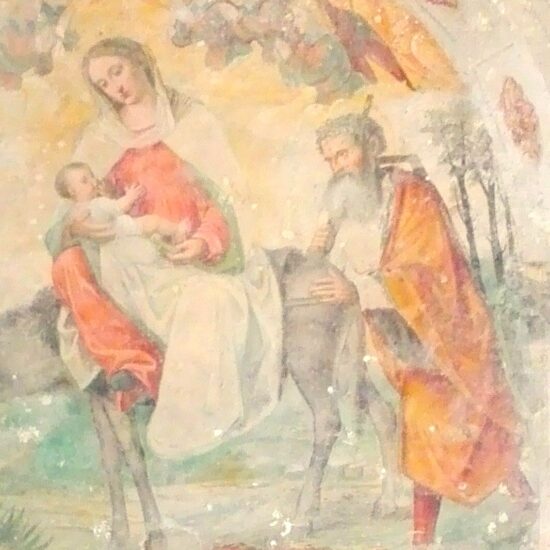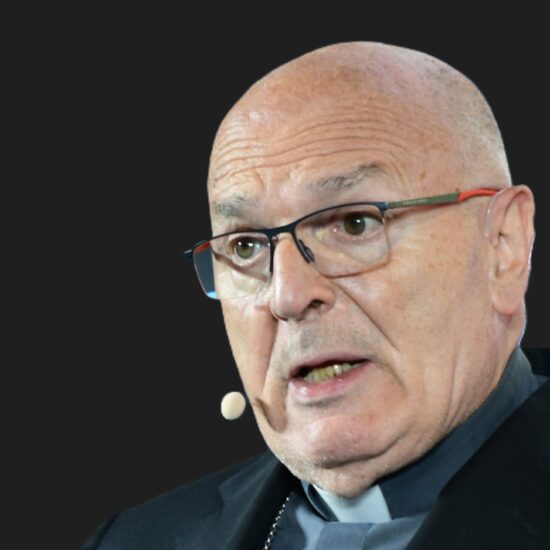Per ricordare, a 10 anni dalla morte, don Francesco Ventorino, è stato qui pubblicato il video della presentazione del volume Ministero della bellezza. Il sacerdozio cattolico di don Francesco Ventorino, svoltasi al Meeting di Rimini (24 agosto 2011), con gli interventi di mons. Luigi Negri e dello stesso autore. Di seguito la trascrizione.
Intervento di mons. Luigi Negri
Il libro si presenta con una tale chiarezza, con una tale organicità, con una tale completezza che risulterebbe inutile una riproposizione analitica. Io vorrei raccogliere alcune suggestioni vivissime che ho avuto leggendo questo testo, che è un grande testo, si potrebbe dire banalmente, di spiritualità. Se il termine spiritualità non fosse abusato e addirittura disintegrato dall’uso comune. Sant’Ambrogio da Milano, che è un grande padre della Chiesa, non solo di Milano, di tutta la Chiesa, in una sua omelia chiedeva: dove troveremo il regno di Dio? Dove lo sorprenderemo il regno di Dio? Nella vita di un presbitero credente. Credo che sia l’unico punto della tradizione in cui è formulato con chiarezza quello che poi lo stesso magistero ecclesiastico ha recuperato, non senza gradualità e con qualche fatica. Vuol dire che il prete o è l’espressione piena della fede cristiana, che è vissuta da un uomo, oppure il prete perde qualsiasi giustificazione, prima ancora che ecclesiale, umana.
Allora occorre che ci sia un uomo. Se non c’è un uomo non ci sarà un prete, come se non c’è un uomo non ci sarà un cristiano. E l’uomo è una domanda, l’uomo è una tensione, l’uomo è una inesorabile capacità di aprire continuamente la sua intelligenza e il suo cuore verso un oltre di cui avverte la presenza. Questo è il mistero della vita umana. Avvertire inesorabile la presenza e non meno inesorabile la lontananza. Ecco, come dire, occorre riproporre il cammino della fede per capire il senso, il significato, la funzione, la posizione del presbitero, del prete nella Chiesa e per la società. Per questo ha senso tutto lo spazio che si dà a questa analisi esistenziale, come la definisce don Giussani in alcune bellissime pagine del Senso religioso, – materialmente è una buona parte, è la parte preponderante del volume –; dare spazio alla analisi esistenziale non semplicemente come qualche cosa che si descrive o di cui si parla, ma come la chiamata. Io mi sono identificato con i seminaristi che ti hanno ascoltato e dicevo: speriamo che abbiano capito qualcosa perché una delle due: o si mettevano in moto loro con la loro umanità e allora qualche cosa avrebbero cavato o, se si mettevano di fronte a queste pagine come si mettono normalmente di fronte alle pagine della teologia o della filosofia, non sarebbe successo nulla. Anzi sarebbe soltanto aumentata la presunzione di dire che tu eri di destra, che eri di sinistra, che eri reazionario, eccetera.
L’analisi esistenziale come un cammino inesorabile è inevitabile; e poi lo stupore che questo cammino ha trovato il suo compimento, ha trovato la sua risposta ed è una risposta che non chiude il cammino, la problematica del cammino, ma la riapre continuamente per quella straordinaria valorizzazione di domanda e di risposta, di fede e di ragione, che è il cristianesimo.
Il prete è colui che deve fare il prete per essere cristiano sul serio. Non c’è un’altra ragione. Non può esserci una ragione ecclesiale separata da questa. Non può esserci una valutazione di carattere sociopolitico. Non si può fare il prete per aiutare la gente. Abbiamo sentito anche questo in questi decenni. Non si può fare il prete per tenere alta la coscienza critica dei problemi della società. Uno fa il prete perché, se non fa il prete, non è più cristiano. È la sua modalità d’assumere l’incontro che Cristo gli ha gli ha fatto fare, di assumerlo realmente. E questa è la vertiginosità ontologica del prete. Il prete viene assunto da Cristo come strumento inesorabile della prosecuzione, della sua presenza fisica nel mondo: predicazione, sacramento e funzione educativa, perché il prete è il generatore, il rigeneratore del popolo; è l’educatore, colui che deve portare l’incontro con Cristo alle conseguenze determinanti sul piano dell’intelligenza, cultura, sul piano dell’ethos, carità, sul piano della destinazione della vita, missione. Io che divento prete perché così posso essere veramente cristiano, esercito questa mia vocazione diventando uno strumento, come diceva con una certa brutalità san Tommaso d’Acquino – ma era meglio la brutalità di san Tommaso d’Aquino rispetto a tante altre cose di questi ultimi secoli –, uno strumento che il Signore congiungeva a sé per rendersi continuamente presente. Io credo che questa sia la grande liberazione che un libretto come questo porta nella vita di tanti, che tanti non sono mica tanto, ma insomma, di quelli che si preparano al sacerdozio perché toglie ogni equivoco di tipo moralistico, di tipo sociologico, di tipo psicologistico. Il prete non deve fare lo psicanalista fai da te.
Il prete non deve supplire a mancanze di carattere psicologico e affettivo della sua gente, invadendo molte volte in maniera assolutamente indebita gli spazi della coscienza che sono sempre da adorare perché è nella coscienza, come ci ha insegnato il Concilio Vaticano II, che Dio parla all’uomo. Ma il prete è un’altra cosa, è il capo della comunità, è colui che rappresenta Cristo nella comunità e lo rappresenta nella densità di una presenza. I Padri del Concilio di Trento, che quasi non si cita più – come se si fosse passati da quelli lateranesi, secondo, terzo, al Concilio Ecumenico Vaticano II –, introdussero un semantema nuovo quando dovettero discutere dell’eucaristia, ma discutendo dell’eucaristia discutevano della sacramentalità della Chiesa, quando hanno detto che l’eucaristia rappresenta Cristo, cioè rende presente Cristo. Il prete rappresenta il Signore, cioè lo rende presente e svolge tutta la forza misericordiosa della sua presenza e tutta l’azione educativa tesa alla formazione di un popolo o meglio alla formazione di ogni singola persona in questo popolo. Per questo non si deve interessare della politica, della sociologia eccetera, perché se ha creato un popolo cristiano, libero, intelligente, sarà il popolo che fa le sue scelte culturali, sociali e politiche. Quante volte ho detto alla CEI, come dire, guadagnandomi quella stima che aumenta… quante volte ho detto, «Ma cosa dobbiamo fare noi vescovi? Dobbiamo dire noi se devono esserci le moschee o se non devono esserci le moschee, se devono respingere quelli che vengono da noi… Dobbiamo creare degli adulti laici, dei cristiani autentici, come ha detto il Papa ai cristiani del Montefeltro, presenti, coerenti e intraprendenti. L’immagine di prete che esce da questo libro è questa.
Siccome la pienezza della vita cristiana è l’unica cosa vera della vita umana e della storia e la verità è legata alla bellezza, allora il prete che fa nascere il popolo cristiano, che lo educa, che lo corregge, che lo perdona, eccetera, è un ministro della bellezza, perché la bellezza non è un’astrazione. La bellezza è Gesù Cristo, come diceva Gregorio di Nissa, e la bellezza di Gesù Cristo si riflette nella vita del popolo che di Cristo porta l’immagine e il segno.
Seconda e ultima notazione. Come me, siamo distanti di pochi anni, ma non tantissimi, credo che anche don Ciccio stia facendo un’esperienza straordinaria di recupero della propria giovinezza, non in modo nostalgico, di recupero della propria giovinezza per tutti i tempi ed i passaggi e gli incontri e i valori che queste circostanze hanno … Faccio un esempio: lui parla del suo rettore del seminario. Mi spiego, non so se 20 anni fa ne avrebbe parlato così. Io non scrivo del mio rettore di seminario perché era evidentemente un po’ diverso dal tuo, ma io ho recuperato, sto recuperando, la provvidenzialità di certi momenti. Adesso mi sembra di dover dire che la storia, che è passata per la mia vita attraverso il seminario che sono stati anni duri, è stata un’esperienza provvidenziale, l’incontro solo con don Giussani, l’incontro solo con Giovanni Paolo II, che, come ho detto per il mio libro di prima, sono i due grandi incontri della mia vita, non sono separati da quella fitta, quotidiana esperienza di incontri che man mano che il tempo passa uno si trova addosso in modo pertinente e perentorio. Il suo rettore del seminario che era più capace di affrontare i problemi della sessualità dei preti più di questi para psicanalisti che distruggono la vocazione dei preti come distruggono le famiglie, no? Il suo rettore. Ma tutta la gente che hai incontrato tu, tutta la gente che ho incontrato io non fanno parte della nostra vocazione? Non fanno parte del nostro sacerdozio? Non sono fattori di insegnamento che si è continuamente aperto nella nostra vita. Io ho conosciuto don Ciccio, perfettamente ero ancora studente universitario a Costa Lunga a delle vacanze di GS eravamo o nel 59 o nel 60 o nel 61. Sessanta. Ma la promessa di Costa Lunga si è realizzata nella nostra vita come Dio ha voluto, nella buona e nella cattiva sorte, nella salute, nella malattia, nella gioia e nel dolore. Abbiamo fatto anche esperienza di questo, dolore non solo morale ma anche fisico. Ecco ho detto subito che avrei presentato questo libro perché mentre leggevo mi sembrava un pezzo della mia storia. Forse lui mentre lo scriveva pensava qualche pezzo della sua storia che sono io, ma è una cosa straordinaria.
Allora, concludo tutto con una citazione… secondo me, quando uno dice con verità queste cose, deve prepararsi perché forse sta arrivando la fine. Pietro di Caron che è stata una grande immagine della vocazione cristiana nel libro di Claudel dice: «Ho sempre pensato certo che la gioia era cosa buona, ma ora ho tutto. Tutto possiedo sotto le mie mani, come chi, salito sulla scala, sull’albero carico di frutti, sente che al peso del suo corpo cedono i rami folti. Bisogna che io parli sotto l’albero come il flauto che non è né basso né acuto. La gratitudine dissuggella la pietra del mio cuore. Oh, così io viva, così io cresca unito al mio Dio, come la vite e l’ulivo». Io credo che sia la nostra esperienza quotidiana. Grazie.
Intervento di don Francesco Ventorino
E invece mentre parlava Monsignor Negri con il quale abbiamo celebrato già le nozze d’oro per stare alla metafora che ha fatto Zamagni prima, infatti lui parlava del ‘60 e quindi sono cinquantuno anni che ci conosciamo. Pensavo a quello che san Tommaso dice dell’amicizia e Tommaso d’Acquino dice che l’amicizia stabilisce una sorta di connaturalità tra le persone. Ecco, io ho sperimentato questa connaturalità mentre lui parlava di me e del mio libro. È una connaturalità per la quale lui sa parlare, meglio di me, di me e del mio libro stesso. E Tommaso definisce questa connaturalità: oltre ad avere come fondamento l’ontologico, cioè la stessa natura umana e, in questo caso il sacramento dell’ordine – io in un grado minore di quello di Monsignor Negri, presbiterato ed episcopato –, Tommaso dice che questa connaturalità nasce dalla capacità di compiacersi delle stesse cose, cioè piacciono le stesse cose. Si è amici perché piacciono le stesse cose, nel senso forte della parola come la usava Tommaso d’Acquino, come soddisfazione intera dell’umanità. Ecco, ho fatto questa esperienza di amicizia, ma come si genera questa connaturalità? Mi chiedevo. Chi ha generato questa connaturalità fra di noi? Avere insieme lo stesso padre, lo stesso padre che è Dio, ma che si è fatto conoscere da noi attraverso il volto umano di un padre, don Luigi Giussani. Io non sarei me stesso senza questa figliolanza. Non sarei me stesso senza questa paternità. E per questo il parlare, il sentir parlare di un amico generato dalla stessa dalla stessa relazione di figliolanza, fa risuonare dentro di me quella connaturalità che è gratitudine immensa a Dio perché nel suo infinito disegno di amore, se leggete il libro saprete le ragioni di quello che dico, ha salvato me stesso, il mio ministero sacerdotale proprio attraverso quest’uomo che, nel momento più critico della mia vita, ha saputo offrire, nella sua umanità, il metodo per proporre Cristo a me stesso e a tutti quelli che, dopo, Dio mi ha dato creando, senza che io facessi nulla, quasi un popolo grande attorno a me e attorno a Lui. Ecco, di questo sono grato a monsignor Negri perché ha ridestato in me la memoria di queste cose che qui – ha ragione lui – vanno come sedimentandosi, queste varie tappe della mia vita, con una coscienza ed una sapienza che qualche anno prima non avrei mai avuto e, forse, questo è il segno che il compimento è vicino.